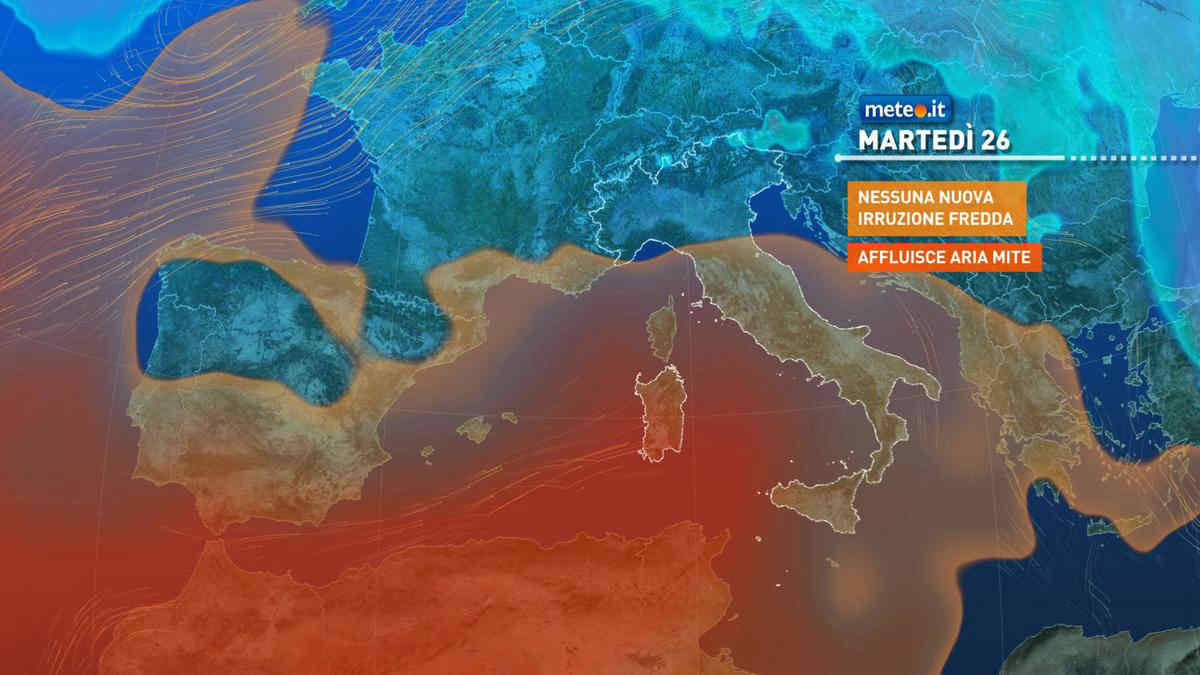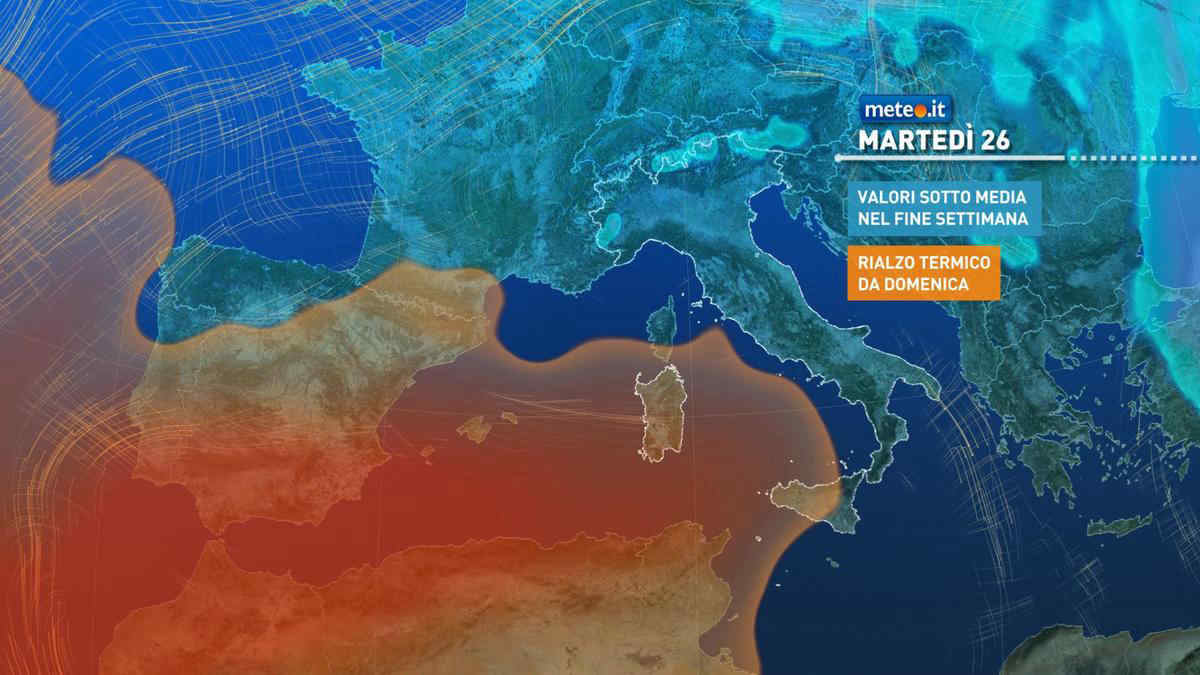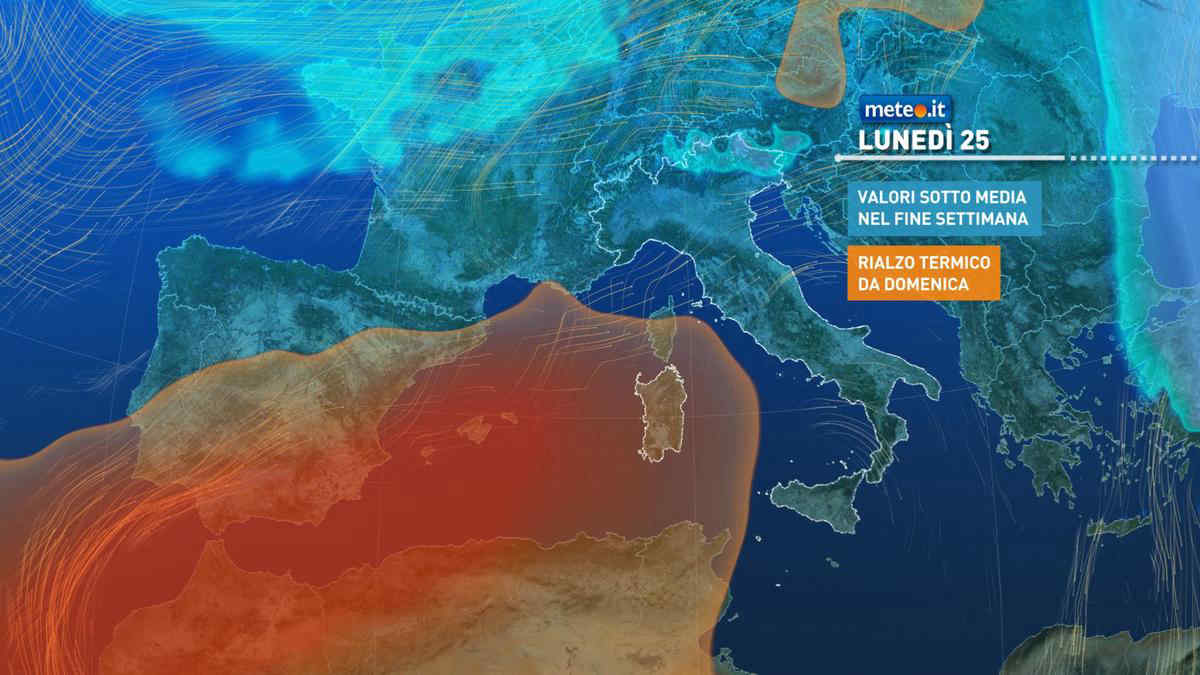Cosa ne sarà dell'accordo di Parigi se gli Stati Uniti lo abbandonano?

La vicinanza temporale parrebbe fin troppo precisa perché si tratti di una mera coincidenza, invece in effetti è proprio il risultato della casualità, o meglio dei vincoli burocratici da rispettare. Fatto sta che il prossimo 4 novembre gli Stati Uniti lasceranno formalmente l'accordo di Parigi sul clima siglato alla fine del 2015, nel preciso momento in cui il popolo statunitense avrà appena espresso le proprie preferenze elettorali per i quattro anni a venire. Le elezioni presidenziali oltreoceano, infatti, sono in programma il prossimo 3 novembre, e sanciranno il vincitore della sfida elettorale tra il repubblicano Donald Trump e il democratico Joe Biden. Come noto, tra le altre cose i due hanno una visione radicalmente opposta del problema climatico.
Sembrano passati secoli - diplomaticamente parlando - da quel 12 dicembre di cinque anni fa, quando l'allora ministro degli esteri francese Laurent Fabius annunciava al mondo il raggiungimento dell'accordo sul clima tra ben 195 paesi partecipanti alla conferenza Cop21. Un impegno formale e condiviso a contenere il rialzo delle temperature globali entro i 2°C, e possibilmente a 1,5°C, in qualche modo orchestrato e promosso dall'inquilino della Casa Bianca dell'epoca, Barack Obama. Con la consapevolezza che il successo dell'accordo passava anzitutto per l'adesione dei tre maggiori emettitori di gas climalteranti: la Cina, gli Stati Uniti e l'Unione Europea.
Un recesso tutto trumpiano
Se c'è un aspetto che appare evidente, anche al netto di tutte le questioni diplomatiche internazionali, è che l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi è frutto del preciso disegno politico del tycoon. "Nel passaggio dall'amministrazione Obama a quella Trump c’è stato uno scarto nettissimo nelle politiche ambientali ed energetiche", spiega a Meteo.it Angela Santese del Dipartimento di scienze e politiche sociali dell’università di Bologna. "Fin dalla scorsa campagna elettorale, Trump aveva definito il cambiamento climatico una bufala e aveva criticato il Clean Power Plan, concepito nel 2014 e siglato l'anno successivo per ridurre l’emissione di anidride carbonica dovuta alla produzione di energia elettrica sul territorio statunitense".
D'altronde, non è certo un segreto che l'amministrazione Trump abbia visto per tutto il mandato una forte presenza di stakeholder legati al petrolio e al gas, in alcuni casi con posizioni negazioniste nei confronti del riscaldamento globale. Il presidente negli ultimi anni ha più volte parlato dell'obiettivo dell'indipendenza energetica statunitense, da raggiungere con l'uso di risorse fossili, ha introdotto sgravi fiscali ad hoc per le società energetiche tradizionali e ha ricalcato diverse iniziative della prima decade del secolo targate George W. Bush.

"Il primo vero passo per l'uscita dall'accordo di Parigi è stato nel marzo 2017, quando con un ordine esecutivo Trump ha autorizzato la costruzione di due oleodotti e ha tagliato il budget della Environmental Protection Agency del 31% e di altre agenzie che lavorano sul cambiamento climatico, come la Nasa", sottolinea Santese. "Di fatto già allora gli Stati Uniti stavano rinunciando agli impegni presi con l’accordo di Parigi, in linea con il principio dell’America first. Una scelta dai precisi tratti politici e ideologici: la volontà di venir meno agli obblighi contratti si associa infatti a una critica del multilateralismo, segno di una visione dei rapporti internazionali in cui gli Stati Uniti puntano a perseguire i propri interessi anche a scapito delle relazioni con gli altri Paesi, alleati inclusi".
Tutto il resto è cronaca, senza grosse sorprese. L’annuncio del ritiro dall’accordo nel settembre 2017, appena un semestre più tardi, con il pretesto che l'adesione stava comportando costi pesanti per gli Stati Uniti e invece irrisori per altri Paesi. Poi la distratta partecipazione di Trump alla conferenza Cop25 di Madrid nel 2019, a cui si è fermato per un quarto d'ora appena, quasi a sottolineare la bassissima priorità data al tema. E l'uscita comunicata formalmente il 4 novembre 2019, nel primo giorno burocraticamente utile per farlo, dando il via a quel count down verso l'uscita effettiva lungo un anno e ormai giunto a conclusione.
Il bivio di novembre
Avrebbe poco senso parlare del futuro dell'accordo di Parigi senza prendere in considerazione l'elefante nella stanza del verdetto elettorale statunitense. In caso di conferma per Trump l'evoluzione sarebbe piuttosto scontata, perché gli Stati Uniti continuerebbero di fatto a non rispettare i termini dell'intesa, come hanno già da tempo iniziato a fare anche al di là dei vincoli formali.

Ma cosa accadrebbe in caso di vittoria per Biden? "La sua posizione pare piuttosto chiara", risponde Santese. "Come ha scritto la scorsa primavera in un articolo pubblicato sulla rivista Foreign Affairs, ritiene il cambiamento climatico una minaccia esistenziale, quindi intende investire massicciamente per sviluppare un’economia basata su energia pulita e che punti ad azzerare le emissioni nette entro il 2050".
Sarebbe dunque una totale inversione di rotta, anche se non si tratta di una posizione cieca alle dinamiche internazionali. "Biden ha detto che nel primo giorno dopo la sua eventuale elezione gli Stati Uniti riaccetteranno i patti sul clima, e che convocherà un summit dei principali paesi emettitori per raggiungere un accordo più ambizioso di quello della Cop21", aggiunge Santese.
Un accordo che, seppur storico, a suo tempo fu molto criticato dal movimento ambientalista perché ritenuto troppo morbido. "Ma Biden ha detto pure", continua la docente, "che gli Stati Uniti si batteranno affinché anche le altre nazioni si impegnino davvero nella lotta al cambiamento climatico, evitando che possano trarre vantaggi economici dal fatto che gli Stati Uniti intendono rispettare gli impegni presi in materia di clima. Un riferimento piuttosto chiaro alla Cina, che oggi cerca di continuare a emettere appaltando ad altri Paesi i progetti che coinvolgono risorse fossili, scaricando dunque una parte dei costi ambientali su terzi".
Il futuro dell'accordo, con o senza gli Stati Uniti
"Anche senza gli Stati Uniti l’accordo di Parigi ha senso di esistere", ha sintetizzato Santese. Certo, il percorso verso la decarbonizzazione totale nel 2060 sarebbe indebolito dalla mancata partecipazione del secondo emettitore di gas climalteranti, sia in termini politici di cooperazione internazionale sia come impatto concreto. Agli Stati Uniti vanno infatti imputate il 15% delle emissioni globali. Tuttavia, dall'altra parte, grazie all'intermediazione della Francia la Cina ha accettato di rispettare i vincoli del patto, scongiurando che l'accordo potesse diventare lettera morta.
Il prossimo primo dicembre l’Italia assumerà per la prima volta la presidenza del G20, e con questa anche la responsabilità di guidare l'applicazione dell'accordo, che peraltro ha proprio nel 2021 il primo anno cruciale di rispetto degli obiettivi comuni. Entro la fine di quest'anno era pure prevista una conferenza dell'Onu sul cambiamento climatico, ma a causa della pandemia è stata già posticipata al novembre 2021. "Sarebbe quello il momento in cui gli Stati Uniti potrebbero riprendere le redini della lotta al cambiamento climatico", conclude Santese, "sia in termini formali sia diplomatici. Ma naturalmente solo se fossero a guida Biden".